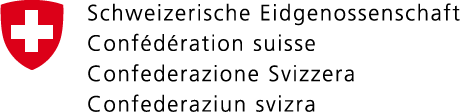COVID-19: cosa resta?
Ritmi serrati, dati che cambiano di continuo e l’esigenza di avere più tempo per la riflessione personale: nel suo contributo apparso sulla NZZ, il consigliere federale Ignazio Cassis ripercorre questo anno straordinario. Chi decide quanto vale una vita umana? Quanto è importante tenere aperte le frontiere? E che cosa avremo imparato quando, prima o poi, si tornerà alla normalità? Una retrospettiva personale.

Che cosa abbiamo imparato dopo un anno di COVID-19? Quali conseguenze ha la pandemia per la salute, ma anche per l’economia e la società? In una retrospettiva molto personale, il consigliere federale Ignazio Cassis ripercorre un periodo intenso e difficile. © Keystone
C’è un’immagine che mi è rimasta in mente: la ripresa aerea di un cantiere. Un formicaio con migliaia di persone, gru e ruspe; un timelapse e al contempo l’istantanea di un’intera generazione. Immortalare la COVID-19 in un’unica immagine è pressoché impossibile, ma ricordo una fotografia che secondo me illustra in modo unico l’inizio di questa crisi: la costruzione di un ospedale a Wuhan.
In un periodo in cui il virus era ancora una malattia respiratoria piuttosto astratta e soprattutto un problema lontano da noi, le autorità cinesi hanno realizzato un progetto edilizio di una portata praticamente inimmaginabile in Europa. Nel settore dell’assistenza sanitaria pubblica, un simile progetto può richiedere, qui da noi, persino 30 anni, anche quando non c’è nessuno che vi si oppone. In Asia, invece, in qualche ora si isolano intere metropoli, si mettono in quarantena 30 milioni di persone e si costruiscono dal nulla nuovi edifici. Ricordo ancora quanto mi affascinava questa immagine, anche se solo per l’impresa tecnica, naturalmente.

Al lupo! Al lupo!
Poco dopo, all’interesse accademico si è aggiunto il coinvolgimento emotivo: il 25 febbraio il dottor Pietro Antonini della Clinica Moncucco di Lugano ha individuato il primo caso di COVID-19 in Svizzera. In Ticino. Nella mia città. Anni prima, durante il periodo della SARS e dell’influenza aviaria, da medico cantonale avevo partecipato ai preparativi in vista della lotta contro una possibile pandemia. La Svizzera si era fatta trovare pronta. Gli esseri umani hanno però due caratteristiche: dimenticano in fretta e fanno fatica ad assumersi le proprie responsabilità. Si corre dunque sempre il rischio di lanciare l’allarme troppo presto.
Se si introducono misure troppo velocemente e l’epidemia non scoppia, si viene accusati di aver reagito in maniera eccessiva. Se si fa troppo poco, si viene tacciati di inerzia. Chi deve prendere decisioni quando la comunità non sa cosa fare ha poco da guadagnare e molto da perdere. Per passare poi dalla teoria ai fatti c’è bisogno non solo di tempo, che per definizione è scarso durante una crisi, ma anche di coraggio: il coraggio di lanciare un allarme quando ancora non si conoscono tutti gli aspetti della situazione.
Stiamo facendo la cosa giusta?
In una situazione di incertezza, aiuta attenersi a processi predefiniti. Per il Consiglio federale ciò ha significato mantenere la calma e fare esattamente quanto prescritto dai piani pandemici. E proprio come avevamo scritto nei piani, in una prima fase la società è stata travolta dall’agitazione. Le persone hanno cominciato a preoccuparsi per qualcosa che in altri momenti si tende a dare per scontato: la salute. Ricordo bene quei giorni, i dati e gli stati d’animo che cambiavano praticamente ogni ora, anche all’interno del Consiglio federale. A volte si aveva l’impressione di volare ad altezze siderali, e altre di essere a cinque metri dall’impatto col suolo. Era come stare su un ottovolante: si passava dalla sicurezza sanitaria nazionale all’approvvigionamento dei negozi a livello locale.
Era assurdo. Era una corsa senza alcun tipo di riscaldamento. E soprattutto stavamo iniziando a correre senza sapere se si sarebbe trattato di una gara di velocità o di una maratona. Governare all’improvviso la Svizzera sulla base del diritto di necessità e intervenire con pieni poteri è stata un’esperienza nuova e quasi inimmaginabile. Dalla Seconda guerra mondiale ad oggi, in Svizzera non era più stato necessario gestire una crisi applicando il diritto di necessità. Mai nella nostra storia è stato erogato tanto denaro per la gestione di una crisi. Tutto ciò si è tradotto in notti insonni e nell’assillante ripetizione di una domanda: stiamo facendo la cosa giusta?

Con il tempo, mettendo le cose in prospettiva tutto risulterà più chiaro
Anche se i libri di storia ci insegnano che in situazioni di emergenza bisogna salvare donne e bambini, noi ci concentriamo sui più anziani e sui malati cronici. È giusto? È sbagliato? Chi determina il valore economico di una vita? Con il diritto di necessità è il Consiglio federale a decidere. Una responsabilità enorme che richiede una riflessione per cui sarebbe obbligatorio prendersi il giusto tempo, anche in una situazione di crisi. Ma i ritmi sono troppo serrati per dedicarsi a questioni etiche e socio-filosofiche. Questa discussione mancata cela però un potenziale conflitto.
Il Consiglio federale è pronto a mettere a disposizione 40 miliardi di franchi, ossia il 40% del prodotto interno lordo svizzero. Spendere così tanto denaro, che non abbiamo, e generare pertanto debiti a carico delle prossime generazioni porta a un conflitto generazionale così spiacevole, che praticamente nessuno ne vuole parlare. Solo con il senno di poi capiremo se abbiamo agito in maniera corretta.
L’economia nemica della salute
Attualmente la società non ha il tempo per confrontarsi con domande di questo tipo e soprattutto non riesce a metterle in prospettiva. Per paura di ritrovarci dalla parte sbagliata, preferiamo non prendere posizione. Chi è dalla parte della salute è contro l’economia e chi vuole salvare l’economia sacrifica vite umane: una discussione superficiale – frutto del nostro benessere – in cui tutto o è bianco o è nero. I Paesi poveri non hanno dovuto affrontare questo dilemma perché le loro finanze semplicemente non glielo permettono. In molti Paesi la salute e il benessere non sono qualcosa di scontato, in molte culture la morte fa parte della vita; la caducità dell’essere è parte della discussione sviluppatasi a livello sociale.
In Svizzera per molto tempo la questione non si è posta. Il benessere della Svizzera si basa sui suoi risultati economici. Chi pensa che salute ed economia siano opposte ignora che il reddito è il fattore decisivo per lo stato di salute di un popolo. Economia e salute sono due facce della stessa medaglia. La loro contrapposizione è fittizia e il conflitto è inutile e deleterio. Per sopravvivere, una società ha bisogno di persone sane, di lavoro e di denaro. La prosperità non si contrappone alla salute, ma ne costituisce la base.

Chiudete le frontiere per salvare vite!
La frustrazione legata all’aspetto moralizzatore del nostro modo di pensare e di agire mi assilla da ormai un anno. È un atteggiamento logorante e non potrebbe essere più lontano dalla realtà dei fatti. Come se per affrontare una crisi ci si potesse basare su uno schema «vero o falso». Se la pandemia ci ha insegnato qualcosa, è che un approccio agile basato su prove ed errori non porta certo alla soluzione perfetta, ma è sicuramente migliore di una concezione centralista che contrappone i due pilastri principali del nostro benessere. Nemmeno la Svizzera è un’isola benedetta dal Signore in cui il benessere è assicurato.
Dobbiamo la nostra prosperità e il nostro avanzato sistema sanitario innanzitutto al nostro efficiente sistema economico, e non da ultimo alla nostra forte economia di esportazione. Proprio in una fase di crisi generale della globalizzazione, in cui le frontiere nazionali diventano nuovamente importanti, ora si solleva anche la richiesta di chiudere i confini: dalla separazione si passa all’isolamento. La COVID-19 ha riportato in primo piano la nostra relazione ambivalente con l’identità nazionale e adesso la politica e i media trattano i temi legati allo sviluppo sociale emersi negli ultimi anni.
Le regioni di frontiera come spazi economici e di vita comune
Le discussioni sulla chiusura delle frontiere erano obsolete già all’inizio della pandemia, che ormai stava per arrivare: credere di poterla bloccare ai confini nazionali era più una chimera fondata sulla paura che un approccio di gestione della crisi basato sulla realtà dei fatti. Il dibattito però ci ha fatto capire quanto sottovalutiamo le regioni di frontiera in quanto spazi di vita comune. I confini non si limitano a separare e ad accentuare i sentimenti identitari, ma sono anche il punto in cui si incontrano Paesi e culture creando spazi economici e di vita per migliaia di persone, sono linee di unione. Così, ad esempio, il sistema sanitario ticinese e quello ginevrino hanno continuato a funzionare durante la pandemia anche grazie ai frontalieri italiani e francesi.
Anche a Costanza e a Kreuzlingen la potenza simbolica di queste linee di unione e non solo di separazione si è fatta sentire: il coinvolgimento emotivo e la protesta collettiva, nata in seguito al ritorno temporaneo di recinzioni al confine, sottolineano quanto siano ancora vivide nella memoria collettiva le immagini della storia sociale europea. Viviamo, amiamo e lavoriamo in queste regioni non nonostante le frontiere, ma grazie a loro e con loro. Una chiusura totale della Svizzera è comunque sempre stata fuori discussione: certo, abbiamo parlato di «chiusura delle frontiere», ma nei fatti queste sono sempre state aperte per le merci e, in parte, anche per le persone.

La sovranità cantonale nella consapevolezza collettiva
In quanto cittadino di un Cantone di frontiera, mi è molto chiara l’importanza dei confini che uniscono oltre che separare. Durante la pandemia non ho potuto fare a meno di pensare più volte all’unicità di questo bene culturale in occasione dei miei viaggi settimanali a Berna. In Ticino abbiamo vissuto un dramma che si fermava al portale sud della galleria del San Gottardo. Attraversavo la galleria e sembrava che la pandemia venisse fagocitata dalla sua oscurità. Credo che la COVID-19 abbia messo in risalto, nel bene e nel male, le varie componenti geografiche e culturali della Svizzera. Il fatto che l’epicentro europeo della pandemia fosse a Milano e che il Ticino sia stato colpito molto prima e in maniera molto più forte rispetto al resto del Paese, ha portato a una profonda differenza nella percezione della situazione.
La pandemia ha mostrato con chiarezza che la Svizzera funziona in modo diverso a seconda del posto in cui ci si trova, ha messo in luce le nostre differenze, ma anche l’unione collettiva che si manifesta nella sovranità cantonale. Il federalismo non è un semplice slogan ereditato dalla nostra storia, ma la rappresentazione di una realtà culturale e geografica. Ancora oggi, la storia del federalismo può essere definita come un continuo lavoro teso a mantenere l’equilibrio: un po’ più di Confederazione da una parte e un po’ più di Cantoni dall’altra.
È presto per cantare vittoria
Il potere dà dipendenza, a tutti i livelli, ma c’è un antidoto: il federalismo, che ci costringe all’umiltà, alla tolleranza e ad accettare chi la pensa diversamente. Proprio i faticosi negoziati, le discussioni infinite e la ripartizione chiara delle responsabilità rappresentano la base della nostra coesione nazionale. Ma il federalismo ha bisogno di senso civico, soprattutto in tempi di crisi. Una virtù che nell’ultimo periodo è andata un po’ persa, sovrastata dal frastuono della guerra di trincea relativa alle misure. Mentre nella primavera scorsa lottavamo come collettività unita contro questo virus sovrumano, più passa il tempo, più i toni si fanno accesi. Alcuni chiedono misure più severe, altri i tanto attesi allentamenti. Invece che ascoltarsi a vicenda, si urla sempre più forte. Invece di andarsi incontro, si cerca lo scontro.
Soprattutto in un momento come questo sarebbe bene ricordare i nostri valori federalistici. Tenere duro darà i suoi frutti. L’aumento delle capacità di test, il tracciamento dei contatti e i vaccini rappresentano un barlume di speranza all’orizzonte. Dobbiamo però essere pronti a continuare insieme il percorso intrapreso. In un momento in cui, con l’arrivo della primavera, l’ottimismo comincia a farsi timidamente strada, pende su di noi la minaccia di una terza ondata – e di una nuova demoralizzazione invernale. Sta a noi non farci abbattere. Sta a noi lottare, insieme, per l’agognata libertà.
Questo contributo è apparso sulla NZZ il 6 aprile 2021.